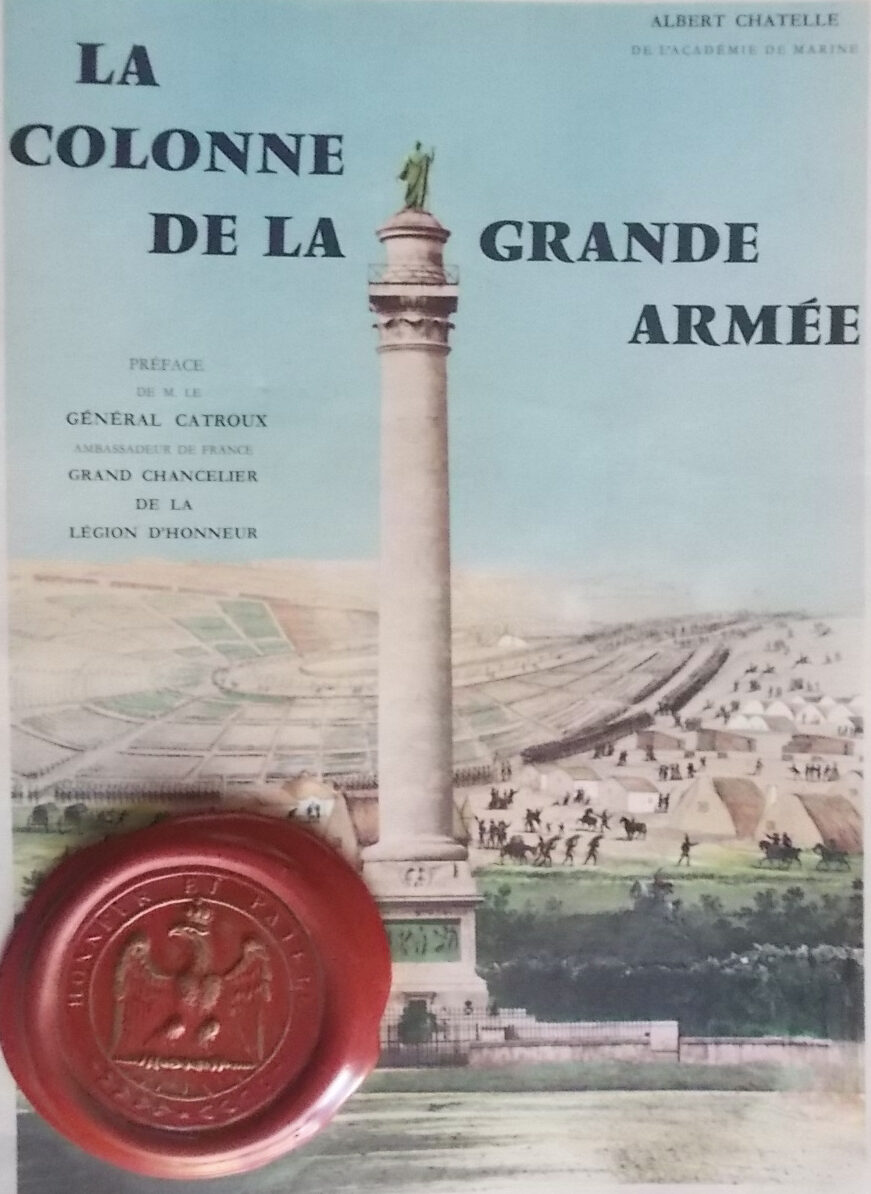I piemontesi della Guardia Imperiale
È noto come la lunga epopea napoleonica avesse coinvolto, fin dal suo principio, migliaia di italiani che inquadrati nelle armate imperiali combatterono con onore e coraggio in giro per tutta l’Europa nei più celebri campi di battaglia da Austerlitz a Ligny.
Note sono le vicende dell’invitto e mai sconfitto esercito del Regno d’Italia (ancora vittorioso sul Mincio nel 1814) o quelle del 111° e 113° reggimento fanteria di linea dell’esercito francese, composti, quasi per intero, rispettivamente da piemontesi e toscani, e così via.
Meno conosciuti sono due piccoli reparti composti da piemontesi e toscani inquadrati nientemeno che nella Guardia Imperiale, la celeberrima forza speciale dell’imperatore Napoleone I: si trattava dei veliti di Torino e Firenze.
I Veliti di Torino
Il battaglione “Velites de Turin” fu costituito con decreto imperiale del 24 marzo 1809, dato al Palazzo delle Tuileries a Parigi, con lo scopo di proteggere a Torino il governatore dei dipartimenti d’oltralpe, principe Camillo Borghese, cognato dell’imperatore avendo a suo tempo sposato la bella Paolina Bonaparte. Il battaglione venne da subito inquadrato formalmente nella Guardia Imperiale e fu accasermato a Torino nell’odierno “Palazzo Campana”, dove rimase fino al 20 maggio 1814 quando, con il rientro dei Savoia in Piemonte, la struttura fu restituita ai padri filippini originariamente insediati nell’edificio (ne erano stati allontanati, infatti, nel 1801 in seguito alla soppressione dell’ordine per disposizione delle autorità francesi).
Il reparto si componeva di uno stato maggiore e di quattro compagnie da 150 soldati raggiungendo un organico complessivo di 626 unità comprensive di ventuno ufficiali posti al comando del maggiore Hyacinthe Cicéron (che comanderà il battaglione fino al suo scioglimento) e 605 uomini tra sottufficiali e truppa.
Requisiti d’accesso al reparto erano una sana e robusta costituzione, un’altezza minima di metri 1.70, il saper leggere e scrivere ed infine una rendita sicura propria o dalla famiglia di almeno 200 franchi. Inoltre, era fondamentale aver compiuto il diciottesimo anno di età.
In un primo tempo gli ufficiali ed i sottufficiali formatori furono prelevati dalla Guardia Imperiale le cui uniformi ed armi venivano utilizzati dal battaglione stesso secondo le linee guida adottate dai fucilieri della “garde”.
Appartenere al reparto divenne un piccolo trampolino di lancio per molti giovani, poiché, appartenendovi per due anni, si ottenevano i gradi di sergente ed il diritto all’incorporamento nelle truppe di linea con tale grado.
Il battaglione ebbe vita relativamente tranquilla nei suoi primi anni per poi essere mobilitato nel 1812, fermandosi, per sua fortuna, in Germania e risparmiandosi l’ecatombe russa.
Prese parte però alle campagne successive a partire da quella di Sassonia nel 1813, per essere incluso, nell’agosto stesso, nella quarta brigata di fanteria della guardia (Divisione Curial) con i granatieri della guardia sassoni ed il battaglione d’élite polacco, partecipando alle battaglie di Lipsia ed Hanau. L’anno successivo i Veliti di Torino presero parte alla campagna per la difesa del territorio francese minacciato dalle forze della coalizione partecipando agli scontri di La Rothiére, Montmirail, Laon e Fére Champenois.
Il 27 aprile 1814 il principe Borghese, in seguito al disastroso esito della campagna, ordinò lo sgombero dei presidi francesi da Torino e, con il ritorno dei Savoia il 15 luglio, il glorioso battaglione “Velites de Turin” venne definitivamente sciolto e concluse così la sua breve storia che abbiamo voluto ricordare. Dai registri delle concessioni della medaglia di Sant’Elena, in parte consultabili in rete, riemergono oggi nomi di soldati che, alcuni chiaramente, altri probabilmente, combatterono nei Veliti di Torino. Pochi rispetto ai moltissimi che vi prestarono servizio, ma questi certamente erano viventi nel 1857 quando la decorazione fu istituita. Anche loro videro i moti risorgimentali e le guerre d’indipendenza: Antoine Fortuné Ardissone, un Bonchetti di cui si sconosce il nome, Jean Dalmazzo-Vaudagnotto, Julien Amant Constant Girard, Jean Baptiste Jorietti, Jean Morello e chissà quanti altri che non conosceremo mai.
L’equipaggiamento
L’armamento base era il fucile evoluzione del moschetto modello 1777 “Charleville” in uso presso la maggior parte dei reparti di fanteria della Grande Armata, il quale, tra l’altro, veniva prodotto anche dalla manifattura imperiale di Torino, ma non solo.
Funzionava a pietra focaia ed aveva un calibro di 17,5 mm ed un peso di 4,375 kg con relativa baionetta di 45,6 cm a sezione triangolare del tipo oggi vietato da tutte le convenzioni internazionali. Lungo circa un metro e mezzo poteva raggiungere quasi i due con la baionetta innestata.
Moschetto modello 1777 “Charleville”
Altra arma individuale tipica era la sciabola “Briquet” diffusamente utilizzata dalla fanteria della francese.
Aveva una lama corta di circa 59 cm per una lunghezza totale di circa 75.
Il curioso nome, che in francese indica l’accendino, gli fu attribuito dalla cavalleria che intendeva fare ironia sulla piccola lama portata dalla fanteria, in quanto le ridotte dimensioni della stessa (se si paragona alle enormi sciabole dei corazzieri ad esempio!) e la particolare forma della guardia potevano vagamente ricordare gli acciarini usati nei bivacchi.
L’uniforme
L’uniforme indossata dai veliti era quella ordinaria dei fucilieri della Guardia Imperiale con shakò ed equipaggiamento della fanteria.
La truppa indossava la giubba di panno blu con bottoniera dorata cui i bottoni d’ottone erano caricati dall’aquila imperiale, tipici di tutti i reparti della “garde”. La stessa aquila faceva bella mostra di sé sulla giberna e sul copricapo posta sopra la coccarda tricolore. Lo shakò era poi decorato con un piumetto rosso vivo (ed ove previsto con galloni laterali arancioni) come le spalline a frangia e le manopole dell’uniforme.
I sottufficiali indossavano poi sulla stessa uniforme i galloni e le finiture dorate tipiche della loro posizione.
Gli ufficiali indossavano un’uniforme simile, ma meglio curata, munita di spalline dorate e di una gorgiera di eguale colore portata sul petto. Anche lo shakò portava cordelline dorate ed una fascia superiore in velluto su cui erano disposte in successione delle stelle dorate. L’aquila con la coccarda tricolore ed il piumetto scarlatto inserito in una coccarda dorata completavano il copricapo.
Finiture di colore arancione chiaro erano portate al bavero ed ai polsini della giubba dai “tamburini”.
Il vessillo
Il reparto ricevette anche la sua bandiera dall’imperatore, la stessa che è conservata a Torino presso il Museo Nazionale del Risorgimento. Al recto riportava la scritta: L’EMPEREUR DES FRANÇAIS AU BON DE VÉLITES DE TURIN ed al verso: GARDE IMPÉRIALE – VALEUR ET DISCIPLINE.
Note
Per quanto riguarda la nomina del principe Borghese in Piemonte nel 1808, pare che la moglie Paolina Bonaparte avesse giocato un ruolo chiave. Si dice avesse convinto l’imperatore con le seguenti parole: “Camillo è un imbecille e nessuno lo sa meglio di me. Ma qui sta il punto, no? gli stiamo affidando il governo di un territorio, è perfetto!”.
Jean-Baptiste Antoine Hyacinthe Cicero (1778-1840) fu dapprima un soldato, poi un sottufficiale ed infine un ufficiale francese in servizio per tutto il ventennio napoleonico. Si fece onore nella campagna italiana del 1796 (fu ferito a Novi) ma anche ad Austerlitz. Battaglia che gli valse il trasferimento nella Guardia Imperiale. Venne decorato, tra l’altro, della Legione d’Onore. Si comportò assai bene in tutte le successive campagne e, dal 1810, ricevette il comando dei Veliti di Torino. Il suo valore nella battaglia di Dresda del 1813 gli valse anche la croce dell’Ordine della Riunione. Dopo un periodo di difficoltà, seguito alla restaurazione dei Borbone, riprese la carriera militare fino alla promozione a colonnello nel 1830.
La medaglia di Sant’Elena
L’esilio dell’Imperatore
Dopo la drammatica battaglia di Waterloo, quando l’Armée era stata sconfitta per una serie di imprevisti e di circostanze sfortunate, Napoleone aveva immaginato dapprima di trasferirsi negli Stati Uniti per dedicarsi alla Scienza e poi in Inghilterra.
Gli inglesi, pieni di rancore verso di lui, gli concessero un pezzo di terra inglese ma non gli dissero dove e lo imbarcarono su di un veliero per condurlo nel luogo prescelto per l’esilio.
La nave giunse, il 16 Ottobre 1815, nel piccolo porto dell’Isola di Sant’Elena, posta nel cuore dell’Oceano e lontana intere giornate di navigazione dal resto del mondo.
Qui Napoleone fu relegato, con un piccolo seguito di attendenti, in un casolare presso la località di Longwood.
Isolato dalla civiltà ed abbandonato ad una misera e malinconica esistenza, egli iniziò a dettare il “Memoriale di Sant’Elena” vero testamento spirituale e politico. Sotto la ferrea sorveglianza di Sir Hudson Lowe, Napoleone visse con sofferenza interiore e fisica gli ultimi anni della sua vita in una località dal clima insidioso per la sua salute.
Lo stomaco, che da sempre gli aveva causato problemi, iniziò via via a peggiorare anche a causa della vita dura impostagli dai sorveglianti e, come si diceva, dal clima poco salubre dell’isola. Il 5 Maggio 1821 alle 17.49 pronunziò le ultime parole “Francia, l’armata e Josèpine” i grandi amori della sua vita, quindi spirò.
Aveva chiesto di essere sepolto sulle sponde della Senna ma nemmeno questo gli fu concesso dagli avversari che lo vollero ancora a Sant’Elena. L’Imperatore faceva paura anche da morto per la forza delle sue idee, gli fecero un funerale da generale ma senza clamore, senza rispolverare antiche nostalgie bonapartiste in Europa.
Solo dopo molti anni le sue spoglie furono restituite al popolo francese che le accolse il 15 Dicembre 1840, con una folla immensa, desiderosa d’accompagnare Napoleone alla cappella di Saint Jerome dove riposò fino al trasferimento alla tomba monumentale per lui realizzata nella Cattedrale di Saint Louis des Invalides nel 1861.
Finalmente, dopo anni di solitudine e di esilio doloroso, egli tornava in terra di Francia in mezzo al suo popolo come aveva tanto desiderato.
Storia della Medaglia di Sant’Elena
Napoleone iniziò a dettare le sue volontà il 15 Aprile del 1821 dividendole in tra parti.
Nella terza parte egli decise di inserire un desiderio da realizzarsi per poter ricordare ed onorare tutti quei soldati che lo avevano seguito con fiducia e fedeltà sui campi di battaglia d’Europa.
Un atto di affetto e, in qualche modo, di riconoscenza voluto dall’imperatore in esilio per ringraziare gli uomini che avevano lottato per la gloria di Francia dal 1792 al 1815.
Per realizzare questa decorazione egli stabilì che fosse necessario finanziarla utilizzando denaro proveniente dal proprio patrimonio personale stimato in molti milioni di franchi francesi dell’epoca.
Ma l’operazione fu in un primo tempo irrealizzabile poiché il sovrano imposto dai vincitori, Luigi XVIII, aveva disposto la confisca di tutti i beni del suo nemico odiatissimo, motivo per cui solo nel 1857 fu possibile realizzare il progetto per volontà dell’imperatore Napoleone III.
Il nuovo capo di stato di Francia decretò il 12 Agosto 1857 la creazione della medaglia destinata ai 400.000 reduci delle armate imperiali ancora in vita per «onorare con una distinzione speciale i soldati che hanno combattuto sotto le bandiere della Francia nei grandi eserciti dal 1792 al 1815».
Erano passati 42 anni dall’ingenerosa battaglia nella piana di Waterloo ma ancora erano in vita, come abbiamo detto, almeno 400.000 soldati della Grande Armata la cui età oscillava in media tra i 60 ed i 90 anni. Se si considera che ai tempi della rivoluzione era possibile arruolarsi già a 15 anni è comprensibile come vi fossero ancora molti soldati. E molti sopravvissero a lungo tanto che nel 1895 vi erano in vita
ancora tre decorati della Sant’Elena. L’ultimo di loro, tale Louis Victor Baillot, morì il 3 Febbraio 1898 alla tenera età di 105 anni e dopo 83 anni dalla sua partecipazione alla campagna dei cento giorni. Era nato nel 1793 e militava nell’esercito fin dal 1812.
Ottenere questa importante decorazione era piuttosto semplice ma le concessioni erano molto rigorose. Era necessario dimostrare di aver operato nelle forze di terra o di mare francesi tra il 1792 ed il 1815 senza un minimo di “durata in servizio” o di
partecipazione a precise campagne militari. Era sufficiente presentare documentazione probante rilasciata dalle autorità militari come il congedo, la proposta per la pensione od altri documenti ufficiali.
Se il richiedente non disponeva di nessun documento o li aveva smarriti, la domanda veniva rifiutata.
La prima concessione, in forma molto pomposa, avvenne il 15 Agosto 1857 quando Napoleone III appuntò la medaglia al petto dell’anziano zio Girolamo Bonaparte, fratello di Napoleone I, ormai anziano (aveva 75 anni).
Dopo di lui molti generali, ammiragli ed importanti personalità delle forze armate ricevettero la medaglia dalle mani dell’imperatore.
Il Ministero degli Interni inviò un telegramma alle prefetture il 28 Agosto perché provvedessero in pochi giorni a far pervenire le liste degli avanti diritto tramite la collaborazione dei sindaci dei comuni dei loro dipartimenti. Proclami furono affissi ovunque per invitare i reduci a presentare la propria domanda.
Furono più di 400.000 ma è impossibile avere un dato certo poiché le liste, depositate negli archivi della Legione d’Onore, si persero in un grave incendio nel 1871.
Oggi gruppi di volontari ed appassionati stanno tentando di ricostruire almeno in parte un database dei decorati raggiungibile a questo indirizzo: http://www.stehelene.org/php/accueil.php?lang=it
Ma un ulteriore onore fu concesso a 5.000 tra i più meritevoli soldati, che individuati da una commissione, ricevettero oltre alla medaglia con il suo attestato, anche un premio di 400 Franchi provenienti dall’eredità di Napoleone Bonaparte diventando a pieno titolo suoi eredi. Gli altri ricevettero in ogni caso la decorazione.
Ma non era solo una medaglia, quel pezzetto di metallo con quel nastro era un carico di ideali, di coraggio e paura, di azione ed emozione, di ricordi di una gioventù sacrificata in nome del sogno europeo.
Portare quella medaglia era come gridare al mondo che si era creduto nel futuro della Francia, ed in quell’uomo in redingote che aveva affascinato l’Europa e portato con sé, per la prima volta, soldati di ogni lingua fianco a fianco.
Era il regalo di Napoleone, il suo ultimo pensiero, ancora una volta per i suoi soldati, quelli che aveva raggiunto chissà dove in un triste 5 Maggio di tanti anni prima.
La medaglia di Sant’Elena
La medaglia fu coniata in bronzo di buona qualità e con conio molto bello e nitido. Attorno alla stessa correva una corona d’alloro che terminava all’estremità in quella imperiale sormontata da un globo terrestre con una piccola croce che alle volte, negli esemplari molto vissuti, risulta spezzata e perduta.
Al recto compare il profilo di Napoleone coronato d’alloro, come i cesari dell’antica Roma, con la scritta «Napoleon I Empereur».
Al verso, tutto intorno al corpo stesso della medaglia, è scritto «Campagnes de 1792 a 1815».
Al centro collocata su più righe compare: «A’ ses compagnos de glorie sa derniere pensèe sth Helène 5 Mai 1821».
Il nastro che la reggeva, dall’anello in bronzo, era in seta verde con cinque pali rossi disposti simmetricamente.
È noto che lo scultore che l’incise, di nome Desiderare Albert Barre, ne realizzò delle versioni mignon per i medaglieri di gala di mm 32/18, 23/13 e 17/11 che vendette a circa due franchi al pezzo.
La medaglia oggi si trova con discreta facilità proprio perché concessa in molti esemplari ma spesso si trova con un nastro posto in epoche successive. Il nastro originale, facilmente riconoscibile, aumenta un poco il valore dell’esemplare ed è sempre meglio acquistarla così che con nastri non pertinenti per epoca.
La decorazione era sempre accompagnata dal relativo attestato (cm 29 x cm 19) numerato e registrato, su cui spiccava la riproduzione del recto, in alto in centro, e disposta ordinatamente tale intestazione:
MEDAILLE DE SAINTE-HELENE,
instituée par S.M. Napoléon III
Napoléon I, A ses compagnons de gloire. Sa dernière pensée! Sainte-Hélène, 5 mai 1821
Le Grand Chancelier de l‘Ordre Impérial de la Légion d’Honneur, certifie que a
NOME E COGNOME DELL’ INSIGNITO
ayant servi durant la période de 1792 à 1815, a reçu la Médaille de Sainte-Hélène.
Duc de Plaisance
Gli attestati sono meno comuni delle medaglie anche per il naturale deperimento della carta che ha vita potenzialmente meno lunga di un oggetto in metallo.
Sono particolarmente belli, soprattutto per noi, se concessi a soldati delle regioni italiane annesse all’impero (nel solo Regno di Sardegna nel 1857 vivevano ancora 20.000 reduci dell’armata), del Regno Italico o del Regno di Napoli.
Furono infatti moltissimi gli italiani che ricevettero la Sant’Elena come molti altri europei di varie nazioni come belgi, svizzeri, polacchi, tedeschi ed altri per un totale di almeno 50.000 dei beneficiari non francesi.
In genere la medaglia era conservata in una scatolina di cartoncino bianco sul cui coperchio spiccava l’aquila imperiale è la scritta:
“Aux compagnos de glorie de Napoleon I – Decret Imperial du 12 Aout 1857”.
La scatola in oggetto è decisamente poco comune.
Oggi, a distanza di quasi duecento anni dalla morte di Napoleone, tenere tra le mani una medaglia di Sant’Elena fa pensare. Ai tanti ragazzi caduti sui prati di tutta l’Europa, alla violenza di quegli scontri, allo scontro tra due visioni del mondo. Ma anche se Napoleone avevo perduto a Waterloo ormai un meccanismo si era avviato e ben lo sappiamo noi Italiani che dall’esperienza napoleonica avviammo il lungo processo del glorioso risorgimento nazionale.
La medaglia di Sant’Elena: Varianti
Nella precedente parte abbiamo brevemente analizzato la medaglia e la sua storia in senso generico approfondendo il contesto storico in cui la stessa fu concepita nonché le vicende che portarono alla sua istituzione.
Ritengo interessante analizzare, ora, alcune varianti. Come vedremo furono coniate versioni più o meno arricchite di migliorie, le quali furono forse commissionate da ufficiali di alto rango con una discreta disponibilità finanziaria.
Alcune di queste proprio, per la fattura squisita e per i materiali con cui furono prodotte, divennero dei piccoli gioielli.
Con l’occasione analizzeremo anche qualche “mignon” realizzata all’epoca. Per completezza riporto nuovamente la descrizione anche del modello più diffuso, già presente nella prima parte, anche perché gli elementi grafici generali naturalmente si ripetevano un po’ in tutte le versioni.
Sicuramente è possibile che siano esistite ulteriori e differenti modelli al momento meno noti, tuttavia prendere visione delle più comuni può essere positivo. Non è sempre facile reperirne ma proprio per questo il collezionarle è particolarmente stimolante, soprattutto se ci si ferma un momento a pensare al valore ideale ed ai sacrifici patiti dai decorati.
La medaglia di Sant’Elena: Modello Ordinario
La medaglia è coniata in bronzo di buona qualità e con conio molto bello e nitido. Attorno alla stessa correva una corona d’alloro che terminava all’estremità in quella imperiale sormontata da un globo terrestre con una piccola croce che alle volte, negli esemplari molto vissuti, risulta spezzata e perduta.
Al recto compare il profilo di Napoleone coronato d’alloro, come i cesari dell’antica Roma, con la scritta “Napoleon I Empereur”.
Al verso, tutto intorno al corpo stesso della medaglia, è scritto “Campagnes de 1792 a 1815”.
Al centro collocata su più righe compare: “A’ ses compagnos de glorie sa derniere pensèe sth Helène 5 Mai 1821”.
Il nastro che la reggeva dall’anello in bronzo, era in seta verde con cinque pali rossi disposti simmetricamente.
La medaglia di Sant’Elena: Modello Argentato
La medaglia era in origine una di quelle ordinarie del tipo distribuito dallo stato ai veterani. Veniva trattata con un bagno in argento per poterne ottenere un’argentatura uniforme che con gli anni, in qualche punto, ha iniziato a ritirarsi lasciando intravedere il caratteristico color “cioccolata”.
La medaglia di Sant’Elena: Modello Dorato
Anche questa medaglia era in origine una di quelle ordinarie del tipo distribuito dallo stato ai veterani. Veniva trattata con un bagno in oro per ottenerne una doratura uniforme. Si tratta di una lavorazione di grandissima qualità ed infatti oltre a non risentire il “peso” degli anni, è rimasta meravigliosa ed ancora oggi stupisce per bellezza.
La medaglia di Sant’Elena: Modello ibrido dorata ed argentata
A differenza delle precedenti, questa medaglia non era in origine una di quelle ordinarie del tipo distribuito dallo stato ai veterani.
Si tratta di un modello realizzato sicuramente da un’oreficeria di grandissima capacità. Una produzione diversa, una vera e propria variante di origine privata e di fattura straordinaria. Lascia pensare che il committente fosse un personaggio di alto rango e dotato di notevoli disponibilità economiche.
La corona e la parte centrale in cui è contenuto il busto dell’imperatore, sono in metallo dorato a differenza della corona d’alloro in origine argentata.
È indubbiamente una delle più belle versioni mai comparse e si noti il profilo di Napoleone che pare diverso dalle altre. Il volto appare più severo e quasi più anziano.
La medaglia di Sant’Elena: Modello in Argento
Anche questa medaglia non era in origine una di quelle ordinarie ma si tratta di un’altra variante di produzione privata.
L’esemplare è prodotto mediante fusione invece che con il conio utilizzato in genere e soprattutto è interamente realizzato in splendido argento.
La medaglia è superbamente nitida ed in questo caso l’immagine dell’imperatore è fedele al disegno originale di Barre a differenza di quella analizzata in precedenza.
La medaglia di Sant’Elena: Produzioni Mignon
Come accennai, lo scultore che l’incise di nome Albert Barre, ne realizzò delle versioni mignon per i medaglieri di gala di mm 32/18, 23/13 e 17/11 che vendette a circa due franchi al pezzo.
Anche delle mignon quindi, esistono esemplari di varia fattura e diversi formati, anche perché sicuramente Barre non fu il solo a coniarne.
Alcune portano il nastro diritto come le sorelle maggiori, altre portano il nastro montato a fiocco più o meno voluminoso e munito sul retro di varie tipologie di fissaggio tra cui una coppia di spilloni paralleli.
Di norma sono molto belle con conio di ottima qualità, decisamente non inferiore ai modelli di formato maggiore e spesso sono dei minuti capolavori di oreficeria.
Ne esistono di diverse anche nell’aspetto e sono note almeno queste varianti:
Modello Ibrido Argentato/Dorato con il tipo grande descritto
Modello ordinario color bronzo fedele alla tipologia ufficiale
Modelli argentati e dorati
In qualche caso si possono trovare montate in medaglieri con altre decorazioni quali la “Legione d’Onore” od altre decorazioni ed ordini del periodo.
È doveroso, infine, ricordare che esistono delle Sant’Elena dipinte in tempi non lontani con vernici dorate ed argentate che tuttavia per ora si riconoscono facilmente perché nei punti di contatto non si nota il bronzo originario ma la doratura posticcia.